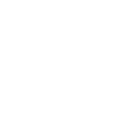Castello di Mesocco
Storia
Il castello di Mesocco
e
chiesa di Santa
Maria del Castello
Werner Meyer – Emil Maure
IL CASTELLO DI MESOCCO
La Mesolcina è una valle alpina lunga e
profonda percorsa dal fiume Moesa che nasce presso il passo del San Bernardino
e confluisce presso Arbedo (Tl) nel Ticino. La Mesolcina non ha valli laterali
di rilievo, a parte la Val Calanca che sbocca a Grono; oltre alla strada del S.
Bernardino, con la quale si raggiunge il Rheinwald, non vi sono vie di traffico
importanti che percorrono la valle, pur essendo essa raggiungibile molto
facilmente da sud. Il fondovalle presenta vari livelli: il più basso, che ha
inizio ad Arbedo, in territorio ticinese (m. 250 circa sul livello del mare),
si protende molto all'interno delle montagne fin dietro Cabbiolo e sale, quasi
impercettibilmente e talvolta compresso fra coni di deiezione, fino a circa m.
450 sul livello del mare. Solo presso Soazza ha inizio la vera e propria salita
che conduce gradatamente in alto fino al Passo del S. Bernardino (m. 2065 s/M).
La possente rocca di Mesocco si erge dal fondovalle al limite estremo del piano
di Mesocco situato ad un'altitudine di 752 m.s.m.
La facile accessibilità della valle da sud,
così come il clima mite, soprattutto nei luoghi più meridionali e soleggiati
(per esempio presso Castaneda), hanno favorito la nascita d'insediamenti umani
già in epoche preistoriche. Numerosi
e anche spettacolari ritrovamenti (tombe, insediamenti, reperti isolati e
recentemente anche tracce di solchi di campi un tempo coltivati) documentano la
presenza dell'uomo nella Mesolcina già dall'età neolitica (ca. 2000 anni a.C.).
Anche nell'area del castello di Mesocco sono stati individuati resti di
insediamenti preistorici. Nella strettoia nord-occidentale della rocca si
trovano fondamenta di abitazioni dell'età del ferro, così come tracce di uno
sbarramento della valle. L'iniziale datazione di questi ultimi alla prima età
del ferro si è recentemente rivelata errata. La fortificazione di sbarramento
risale alla fine dell'antichità classica o all'inizio del Medioevo.
Ritrovamenti di reperti sparsi dell'età del bronzo e del ferro documentano la
presenza di insediamenti preistorici persino sul piano della rocca di Mesocco,
ma mancano ancora oggi tracce di una fortificazione di quell'epoca. In epoca romana tardoimperiale il passo del
S. Bernardino era percorso da una strada di secondaria importanza, in grado di
garantire un rapido collegamento tra la rocca di Bilitio (Bellinzona) e Curia
(Coira) capoluogo della Rezia.
L'isolamento geografico della Mesolcina
favorì nel Medioevo la formazione di un
feudo territorialmente chiuso. Il
castello di Mesocco può esserne considerato senza dubbio il nucleo centrale, la
cui origine n epoca altomedievale non
è seriamente contestabile. Questo ruolo storicamente indicativo merita tanto
più attenzione in quanto il castello di Mesocco si erge in un luogo alto e
isolato nella valle, mentre gli altri castelli medievali della Mesolcina sono
situati nel tratto inferiore, distribuiti soprattutto nell'area di Grono e
Roveredo (San Vittore, Beffano, Palazzo Trivulzio, Boggiano, Torre Fiorenzana,
S. Maria di Calanca). La fortezza più vicina confinante col castello di Mesocco
si trova alla distanza di Km 11 presso Cama (castello di Norantola).
Chi
visita le rovine oggi fatica forse a rendersi conto delle epoche più
antiche del castello. La costruzione è totalmente dominata da mura poderose di
epoca altomedievale e soprattutto tardomedievale. Inoltre gli estesi lavori di
scavo e consolidamento, condotti nel 1925-26 dalla «Pro Campagna», hanno
portato alla luce tratti delle mura più recenti ed è loro merito averli salvati
da un ulteriore deterioramento. D'altra parte, in seguito ai procedimenti poco
scrupolosi un tempo comuni, i reperti archeologici sono stati in gran parte
trascurati e distrutti cosicché al di fuori di un paio di frammenti di mura
all'interno della chiesa di S. Carpoforo (vedi p. 12), non vi è nessun resto
visibile a testimonianza della fortificazione altomedievale. Non è più possibile
dare una risposta ai fondamentali quesiti sulla storia della costruzione e
dell'insediamento che oggi queste rovine suscitano in noi.
In tempi più recenti, la pittoresca
fortificazione situata sul blocco roccioso che domina la valle, è stata
purtroppo danneggiata nel suo fascino originario dalla costruzione
dell'autostrada, la cui ampia fascia di cemento si svolge brutalmente attraverso
la strettoia ai piedi della rocca. Le rovine si possono visitare senza
difficoltà. A nord, ai piedi del castello, sono a disposizione numerosi
parcheggi presso l'uscita dell'autostrada. Tramite un comodo sentiero si giunge
dapprima nell'area delimitata dalla cinta muraria esterna in cui sorge la
chiesa di S. Maria del Castello: poi, sul fianco nordorientale, la strada
conduce in ripida salita all'ingresso della fortificazione principale,
attraversato il quale ci si trova all'interno dell'ampia area delle rovine.
CENNI
STORICI
Il castello di Mesocco costituisce a partire dagli inizi del Xlll secolo, al
più tardi, il centro feudale dell'intera Mesolcina per cui nella storia della
fortezza si rispecchiano le vicende politiche della valle. Per i tempi più
antichi mancano testimonianze dirette. Resta perciò la questione aperta: in
occasione di quale evento fu eretta l'originaria chiesa fortificata
altomedievale. Il patrocinio di S. Carpoforo indica una fondazione della chiesa
molto antica, che ha origine a Milano. Sul finire del primo millennio la
Mesolcina apparteneva probabilmente alla contea della Rezia Superiore, ma poco
sappiamo sulla sua reale situazione politica.
Gli
inizi della dominazione dei de Sacco-Mesocco sulla Mesolcina restano altrettanto
oscuri, tanto più che non è risolta la questione sulla genealogia di questo
casato, documentato per la prima volta con «Heberhardus de Sacco» nel 1137/39.
Si possono solo supporre, ma non dimostrare, legami parentali con gli Udalrichinger
che furono per un certo periodo conti della Rezia Superiore e con il casato dei
Torre, originari della Val di Blenio. Nel sec. Xll i de Sacco-Mesocco hanno in
ogni caso il dominio sulla Mesolcina. Essi ottengono probabilmente questo
privilegio grazie all'appoggio dell'imperatore Federico Barbarossa. Il
progressivo ampliamento dalla dominazione della valle a quella di tutto il
territorio avviene nel corso dei secoli XIII e XIV. Casati minori vengono
cacciati o sottomessi: rami cadetti dei de Sacco-Mesocco risiedono fino al sec.
XV in altri castelli della valle (Norantola, Torre Fiorenzana, Roveredo, San
Vittore, S. Maria di Calanca).
La
prima indiretta citazione del castello di Mesocco è dell'anno 1219 quando viene nominata nei documenti
la chiesa «sancti Carpofori de sorcastelo». Nel 1273/74 viene documentato «in
castro Mesocho» l’inizio del vassallaggio di due coloni walser provenienti dal
Rheinwald durante la signoria di Alberto de Sacco-Mesocco. Le conquiste da
parte dei de Sacco-Mesocco dei territori oltre il passo del S. Bernardino
coinvolgono il casato, durante il sec. XIV, nelle lotte tra i feudatari della
Rezia, ma permettono loro, intorno al 1380, di ereditare i territori dei baroni
di Belmont nella regione della valle del Reno anteriore tra Flims e Ilanz.
Quando, dopo il 1400, la morte di Gian
Galeazzo Visconti provoca disordini all’interno del Ducato di Milano. Alberto
de Sacco-Mesocco si impadronisce temporaneamente dei territori milanesi di
Bellinzona, Blenio e Monte Dongo. Da allora i de Sacco-Mesocco assumono il
titolo nobiliare di conti. Sotto il dominio di Alberto de Sacco-Mesocco,
arrivato al culmine del suo potere nei primi anni del sec. XV, il casato cade
sempre più, negli anni seguenti, sotto l'influenza della Lega Grigia e viene
coinvolto nei conflitti tra i cantoni centrali della Confederazione e il Ducato
di Milano. Nel castello di Mesocco, centro del potere feudale nella valle, si
sviluppa da un lato una dispendiosa vita di corte, caratterizzata da uno sfarzo
principesco, ma dall’altro la potenza dei de Sacco-Mesocco viene continuamente
corrosa da pressioni politiche esterne e difficoltà interne causate dai
sudditi. Nel 1458 i conti Enrico e Giovanni de Sacco-Mesocco stipulano col
monastero di Disentis un contratto di legislazione regionale nel quale
s'impegnano a lasciare libero l'accesso alla fortezza di Mesocco ai monaci.
Per impedire lo sgretolamento del proprio
dominio, nella seconda metà del sec. XV i de Sacco-Mesocco si appoggiano sempre più a Milano; intorno al 1479,
tuttavia, il conte Giovanni Pietro passa, in occasione della battaglia di
Giornico, all’esercito confederato-grigionese. Truppe milanesi, intenzionate a
impossessarsi cautelativamente della fortezza di Mesocco, vengono precedute da
truppe della Lega Grigia che tengono occupata la rocca. Nel 1480 Milano inizia
però trattative col conte Giovanni Pietro per l’acquisto della Mesolcina, ma si
ritira per non irritare i Confederati delegando le trattative a un prestanome,
Gian Giacomo Trivulzio, condottiero e consigliere del Duca, il quale riesce ad
acquistare la Mesolcina il 20 novembre 1480. Questo passaggio di proprietà
scatena nella valle sommosse che si protraggono per molti anni. Già il 23
novembre successivo le truppe della Lega Grigia occupano il castello di Mesocco
per impedire la sua traslazione al Ducato di Milano. Una sentenza federale
porta nel 1481 alla cessione della fortezza al Trivulzio, ma l'opposizione dei
valligiani si placa soltanto nel 1483, quando il Trivulzio si impegna a tenere aperta la fortezza di Mesocco alla
Lega Grigia.
I sudditi irrequieti, la pericolosa vicinanza
dei bellicosi Grigionesi, la precarietà dell'appoggio milanese e altri motivi
conducono, dopo il 1485, al distacco del
Trivulzio da Milano. In quegli anni, con l'aiuto di maestranze italiane,
egli trasforma il castello di Mesocco in un'imponente roccaforte nella quale
deposita una grande quantità di armi e in particolare un notevole parco
d'artiglieria; ciò nonostante, nel 1496, egli entra nella Lega Grigia impegnandosi a rifornire di armi e
provviste le fortezze di Mesocco e Roveredo (il cosiddetto «Palazzo Trivulzi»,
nel quale era collocata una parte dell'amministrazione feudale) e metterle a
disposizione dei Grigionesi in caso di guerra. Nella guerra di Svevia del 1499
in successive campagne militari i Grigionesi approfittano ripetutamente
dell’artiglieria del castello di Mesocco.
Le esperienze della battaglia di Musso
inducono nel 1526 i Grigionesi,
nonostante i timori dei Confederati, allo smantellamento
del castello di Mesocco. Nel 1549 i Mesolcinesi si riscattano dalla
dominazione del Trivulzio entrando a far parte, nel 1551, della Lega Grigia.
DESCRIZIONE
DEL CASTELLO
Il castello di Mesocco si divide nelle
seguenti quattro parti principali:
1. area fortificata antistante (lato est. A)
2. castello (piano della rocca, B)
3. rocca (nucleo centrale del castello. C)
4. area sacra (chiesa di San Carpoforo, D).
L'accesso all'estesa fortezza avviene
attraverso l'avvallamento a nord della rocca, approssimativamente sul tracciato
del sentiero originario. Dirupi scoscesi verso la strettoia nordoccidentale e
giù verso la Moesa profondamente incassata nella roccia e descrivente numerose
anse intorno alla rocca, rendono arduo qualsiasi avvicinamento da altri lati.
Presso la chiesa di S. Maria del Castello si trovano singoli e indipendenti
resti della cerchia muraria esterna dell'area fortificata antistante che
comprendeva anche la roccia a sud-est della chiesa. Apparentemente si tratta di
ruderi di una massiccia cerchia muraria. Entro quest'area fortificata
antistante non vi sono tracce di altre costruzioni.
La
salita al castello inizia presso la chiesa di Santa Maria sul fianco orientale della
rocca. Resta da vedere se fosse previsto il fatto che percorrendo questa salita
un guerriero armato avrebbe rivolto verso la rocca il fianco destro, cioè il
lato del corpo non protetto dallo scudo. Sul fianco meridionale della rocca, la
via d'accesso descrive un tornante verso destra e conduce direttamente davanti
all'ingresso del castello, costituito da una torre sporgente dalla cerchia muraria (1). Un fossato antistante,
scavato nella roccia, era attraversabile un tempo grazie a un ponte levatoio.
All’interno della torre d'ingresso, la strada piega ad angolo retto verso ovest
e conduce attraverso una seconda porta di più antica data nell'area spaziosa
del castello vero e proprio (B). I conci di questa porta in marmo sono stati in
parte ricostruiti.
Il castello si estende su tutto il piano
della rocca, lungo il cui margine scorre una solida cerchia muraria dalla pianta a forma di pentagono irregolare e
allungato (2). Sul lato occidentale e settentrionale lo spessore delle mura è
relativamente esiguo (m 1 ca.) Giunti verticali e orizzontali (sono visibili
tra l'altro feritoie e merlature murate) rendono riconoscibili successivi
sopralzi e rifacimenti. Sugli altri lati, le mura di cinta presentano uno
spessore di diversi metri. Nel punto in cui essa ha conservato la sua altezza
originaria, è coronata esternamente da una fila di triple mensole di pietra che
un tempo sorreggevano una merlatura aggettante. Di tutto ciò non restano che
poche tracce.
La cerchia muraria è rafforzata da cinque torri sporgenti di forma diversa.
Secondo fonti tardomedievali queste torri possedevano nomi oggi peraltro non
identificabili con sicurezza. La torre angolare meridionale (torre Masiza?. 3)
è di pianta rettangolare. Nella sua massiccia muratura si inseriscono i resti
di una costruzione più antica, meno solida. Le feritoie, collocate in celle con
soffitto a volta, permettevano il controllo del lato sud-est della cinta
muraria. Nella torre successiva (La porta col rivellino, 1) era collocata la
porta fortificata (v. sopra). Le sue feritoie servivano per la difesa
dell'accesso e della zona orientale delle mura, ora per buona parte diroccata.
Il bastione più massiccio, oggi conservato solo per metà, sorgeva sul lato orientale
delle mura ed era formato da una possente torre quadrata (La torre grossa, 4)
con mura di uno spessore di più di m 5. Le stanze interne, con soffitti a
volta, erano accessibili dalla corte interna ed erano fornite di feritoie
strombate adatte a pezzi di artiglieria di piccolo calibro (colubrine?), la cui
traiettoria radeva le mura di cinta. Aperture quadrate nelle volte permettevano
la fuoriuscita del fumo dello sparo.
Da una feritoia, inserita obliquamente nel
muro di cinta nord-orientale, era possibile proteggere la zona antistante la
fortezza con la sua via di accesso presso la chiesa di Santa Maria. Nell'angolo
settentrionale della cinta muraria non fu mai eretta una torre vera e propria,
ma solamente un bastione sporgente della stessa altezza del muro perimetrale
(5). Al contrario, l’angolo nord-occidentale dei bastioni era fortificato da
un'altra torre (La torre nuova?. 6) con pianta poligonale irregolare. Nel piano
superiore si trovano i resti di un locale di soggiorno con finestre entro
nicchie fornite di sedili. Nel piano inferiore vi erano stanze con feritoie.
Al di fuori del tratto nord-ovest dei
bastioni, al limite dello strapiombo della rocca, vi sono resti di fondazioni
di una precedente cinta muraria (7). Dai bastioni sud-occidentali si dirama uno
sbarramento (8) che impedisce l'accesso alla spalla occidentale della roccia.
Questa zona sbarrata è accessibile dal castello attraverso una galleria
sotterranea (posterla).
Il
cortile del castello non era originariamente così spazioso come appare
attualmente poiché diverse costruzioni, ora demolite, occupavano un tempo gran
parte della superficie. Nelle fondamenta di una costruzione isolata di forma
rettangolare, situate nel tratto sud-ovest dell’area (9), si possono
individuare, pur mancando una documentazione sicura, i resti dei bagni: mentre
si può sostenere con certezza, in base ai reperti scavati (fornace) e a
documenti tardomedievali, l’esistenza di un edificio adibito a fucina (10),
situato accanto al bastione di fianco al portale d'ingresso. Quanto alle tracce
di mura, rinvenute a sud-est della rocca (11), mancano indicazioni sicure:
forse si tratta di un edificio destinato ad abitazione risalente alla prima
fase costruttiva del castello.
Importanti
spaziose costruzioni testimoniate oggi solo da misere macerie, si
estendevano lungo il lato est dei bastioni. Un lungo edificio, situato proprio
accanto al portale d ingresso (12), conteneva probabilmente le stalle. Più a
nord si trovano le rovine di una costruzione più volte suddivisa e adibita a
servizi e a magazzini. Nel suo lato meridionale (13) era collocato un
caseificio e in quello settentrionale una fonderia (14).In questa ala andrebbe
ricercata anche la zecca della Mesolcina, di età tardomedievale, ammesso che
essa si trovasse veramente nel castello di Mesocco e non nel palazzo Trivulzio
di Roveredo. Infine, all'interno di quest'ala sono venuti alla luce anche i
resti di una grande cisterna scavata nella roccia (15).
Nell'immediata vicinanza della chiesa di S.
Carpoforo, si trovano lungo i bastioni nord-occidentali i ruderi di un edificio
rettangolare a più piani (16). Sul lato corto a sud di quest'ultimo è collocato
un imponente forno. Apparentemente ci troviamo di fronte alle rovine del «forno
centrale»che nel tardo medioevo riforniva di pane i numerosi abitanti del
castello.
L'area
sacra del
castello di Mesocco è costituita dalla chiesa
di S. Carpoforo (17). Sulla base degli scavi fatti, non si è potuto
stabilire se la chiesa originariamente fosse circondata da mura e da un
cimitero, come invece è documentato per Jörgenberg o per Hohenrätien. Il
campanile isolato (18) è una costruzione snella a pianta quadrata, spostata
rispetto all'asse della chiesa. Il basamento presenta arcate cieche tripartite
e regge cinque piani con finestre binate a tutto sesto inserite in cornici
quadrate. Le colonnine per la maggior parte sono state rimosse. La copertura in
lastre di pietra è a piramide tronca. All'interno della navata della chiesa si
trovano alcuni resti di una precedente costruzione con abside allineata. La
chiesa esistente ha per pianta un rettangolo irregolare. Mancano i frontoni
delle facciate est e ovest. La facciata orientale presenta resti di arcate
cieche: su quelle settentrionale e meridionale vi sono nicchie voltate. Piccole
finestre con arco a tutto sesto sono impostate in alto. Due porte introducono
nella chiesa, una sul lato sud e l'altra su quello nord; quest'ultima
probabilmente era l'ingresso riservato al sacerdote e alla nobiltà. Nella
navata costituita da una sala rettangolare vi è un muretto trasversale eretto
successivamente, forse resto di una transenna. L'abside a forma di ferro di
cavallo è ricavata nello spessore della parete della chiesa. Vi sono conservati
i resti del basamento dell'altare. Sopra i singoli frammenti di intonaco vi
sono tracce degli affreschi originali, ancora intatti nel sec. XVII. Nel 1930
Poeschel individuò parti di vesti e drappeggi che egli attribuì al 1460 ca.
La
rocca (C), nucleo centrale del castello, forma un corpo quadrangolare
appoggiato al bastione occidentale, costituito da quattro elementi principali
concatenati:
1. il mastio (torre principale, 19)
2. la corte interna (20)
3. il corpo occidentale (23/24)
4. il corpo settentrionale (il «palazzo», 22/26).
Sul lato orientale del quadrilatero, una
porta al livello del piano terreno conduce all'interno della rocca e
precisamente alla corte lastricata (20). A nord, ai piedi del mastio, si
trovano i resti di una piccola cisterna (21). Il corpo settentrionale, formato
da un possente edificio rettangolare, internamente suddiviso in tre parti, è
conservato solo parzialmente. Davanti al fronte meridionale, sul lato della
corte interna, ora molto diroccato, con porte al pianoterra parzialmente
murate, si trovano le fondamenta di un loggiato costruito in epoca successiva.
Esso era raggiungibile attraverso una scala esterna e dava accesso ai locali
superiori del palazzo (22/26). Al piano terra vi sono tracce di pittura che
imitano un rivestimento marmoreo (inizi del XV sec.). Al terzo piano della
parete settentrionale, ancora esistente, si trovano ampie finestre con nicchie
fornite di sedili in pietra, una nicchia cieca e uno spazioso camino (grazie al
ritrovamento di frammenti di ceramica è documentato un riscaldamento tardomedievale
con stufa di maiolica).
Il corpo occidentale sorse evidentemente in
più fasi costruttive. Sul lato corto a nord, esso è collegato col corpo
settentrionale di epoca più recente. La parte meridionale è da ritenersi
adibita a abitazione per la servitù o per la guarnigione. (23) con ingresso al
piano terra: vi sono i resti di un camino. Nella parte nord, più piccola, si
trova la cucina padronale con focolari e forno sporgente verso il cortile (24).
Sul lato esterno del bastione sono situate, su piani diversi, due latrine con
sedili e relative condutture verticali (75). Il locale con soffitto a volta
accessibile dalla cucina e situato nell'angolo occidentale del corpo a nord,
viene indicato da Poeschel come la stanza di soggiorno della guarnigione,
mentre più verosimilmente si tratta di una dispensa (26). Nel lato sud-ovest
della rocca si trovano le fondamenta di mura di cinta più antiche (27). Il mastio nell'angolo orientale della
rocca (19), oggi conservato soltanto fino all'altezza di m 8 ca., costituiva l'elemento architettonico più possente del
castello altomedievale. La muratura è costituita da blocchi di pietra
squadrati e disposti a file. L'ingresso superiore, situato sul lato occidentale
della torre, è vagamente riconoscibile nella sua impostazione: esso era
raggiungibile da una scala di pietra costruita più tardi e originariamente in
legno. Le pareti nord-est e sud-est della torre principale sono rinforzate da
contrafforti. L'interno della torre è riempito per parecchi metri da detriti.
STORIA
DELLA COSTRUZIONE
La radicale ristrutturazione del sec. XV e
gli effetti distruttivi degli scavi del 1925-26 non permettono di ricostruire
documentatamente l'assetto originario e le successive vicende della
costruzione. Quanto segue si basa perciò soprattutto su supposizioni e su conclusioni
tratte per analogia.
Le sole tracce
visibili della probabile chiesa fortificata altomedievale (sec. Vl-VII?)
sono conservate all'interno della chiesa di S. Carpoforo dove sono venute alla
luce le fondamenta di una costruzione precedente con abside semicircolare.
Sorprendentemente si trova lo stesso tipo di pianta nella chiesa fortificata di
Grepault presso Truns. Di bastioni del Primo Medioevo non v'è traccia, come
pure di edifici destinati a residenza. È probabile che vi fosse stata una
suddivisione dell'area del castello per permettervi l'insediamento di numerosi
membri della comunità.
Nel sec. Xl la chiesa del Primo Medioevo
venne sostituita da una nuova
romanica con abside semicircolare
internamente e con campanile isolato. Resta tuttora ignoto quando si formò il
nucleo del castello feudale. Confronti con altri castelli simili (Hohenrätien,
Schiedberg, Castel Grande di Bellinzona) permettono una datazione risalente ai
secc. X - Xl. I resti databili più
antichi all'interno della rocca, costituiti dalle rovine del mastio,
appartengono alla seconda metà del sec. Xll. Forse le fondamenta di una cinta
muraria, che parte dall’angolo meridionale della torre (27), risalgono a
un'epoca ancora precedente. Inoltre le tracce di fondamenta a sud-est del
mastio (11) potrebbero risalire a un'abitazione del sec. Xl o addirittura del
X.
Con l'ampia ristrutturazione del castello tra il 1150 e il 1200, documentata dalla
costruzione del mastio (19), inizia la
movimentata storia delle vicende costruttive. Nel sec. Xlll al castello di
Mesocco si aggiunge una nuova cinta muraria che partendo alla rocca racchiude
tutta l'area fortificata. Il sec. XIV comporta ulteriori ristrutturazioni:
all'interno della rocca sorge, in due fasi, un corpo residenziale oblungo a
ridosso della cinta muraria (23/24). In alcuni punti le mura vengono
sopraelevate e rinforzate da merli a coda di rondine e tra il campanile e il
bastione occidentale viene costruito un grande forno per soddisfare il bisogno
degli abitanti del castello evidentemente sempre più numerosi (16). Sulle
botteghe artigiane, le stalle, i magazzini ed altri locali di servizio, situati
nella parte orientale del castello (12/15), mancano informazioni storiche di
età anteriore al sec. XV.
Quando i de Sacco-Mesocco raggiunsero nel
1400, con Alberto, l’apice del loro potere, cosa che richiedeva una maggiore
rappresentatività, il castello di Mesocco subì, come centro feudale, una serie
di importanti ristrutturazioni e ampliamenti. Questi ultimi riguardano
in parte i bastioni della rocca (2): viene modificata la porta interna (1) e
viene costruito il muro trasversale anteposto a sud-ovest (8) e forse anche la
torre poligonale a nord-ovest. Soprattutto però verso il 1400 viene modificata la rocca stessa. La pianta quadrata,
già predisposta dall'orientamento del corpo occidentale (23/24) rispetto al
mastio, viene completata dalla costruzione sul lato nord-ovest dell'imponente
palazzo (22/26). I successivi ampliamenti all'interno della rocca (scala
esterna per l'ingresso superiore del mastio, loggiato davanti al palazzo) non
sono databili con precisione. Essi appartengono forse, come il rivestimento
alla base del mastio (19). all'ultima fase costruttiva della fine del sec. XV.
Nel Tardo
Medioevo, il castello di Mesocco
dovette essere un’imponente fortezza
difficilmente espugnabile. Già nel 1478, quindi ancora prima dei grandi
lavori di completamento degli anni seguenti, i governatori di Bellinzona
comunicavano a Milano che la fortezza si poteva conquistare solo per
«tradimento o fame». Dopo l'acquisizione del feudo di Mesocco da parte di Gian
Giacomo Trivulzio nel 1480, iniziarono
i lavori di ampliamento del castello che lo trasformarono
nella fortezza tardomedievale. I lavori incominciarono probabilmente verso
il 1483. Con l'aiuto di capomastri italiani vennero rifatte l'imponente cinta
muraria della rocca e la porta fortificata (1) con le due torri che la
fiancheggiano (3/5). Allora sorse anche l'area fortificata esterna che congloba
nella fortezza la zona antistante ad est con la chiesa di S. Maria del
Castello. Ulteriori ristrutturazioni riguardano gli edifici destinati ai
servizi all'interno del castello.
Un inventario del 1503 informa singolarmente
sulla denominazione e sulla funzione delle mura, delle torri e degli ambienti
del castello. Contiene anche un elenco delle macchine belliche di diverso tipo
e calibro esistenti nella fortezza. Dopo il suo smantellamento nel 1526, una parte di questa artiglieria venne
acquistata dai Grigionesi e da ultimo finì nell'arsenale di Coira.
Dopo di ciò il castello divenne
inutilizzabile come piazzaforte abitata, ma la struttura muraria rimase in gran
parte intatta. Anche la chiesa di S. Carpoforo si trovava fino al 1700 in
discrete condizioni. Una ricostruzione della fortezza, che nel sec. XVII avrebbe
potuto essere attuata con mezzi relativamente modesti, non avvenne mai.
L’IMPORTANZA
DEL CASTELLO Dl MESOCCO NELLA STORIA DELLE FORTIFICAZIONI
Il castello di Mesocco viene descritto da E.
Poeschel (I monumenti d'Arte e di Storia del Canton Grigioni, vol. Vl. p. 366)
come «la fortificazione più importante
dei Grigioni e come una delle più grandi fortezze della Svizzera». Questo
giudizio è esatto per quanto riguarda l'imponenza delle mura ma richiede una precisazione: le mura possenti e le torri per i pezzi
d'artiglieria, che differenziano il castello di Mesocco da altri castelli
grigionesi, sorgono in un'epoca (sec. XV) nella quale era già cessata qualsiasi
attività edificatoria nei castelli feudali della Svizzera. Eccetto le opere di
fortificazione delle città, solamente in alcune residenze di balivi dei
territori confederati (Dorneck, SO) o in castelli di feudatari (Bellinzona, Tl;
Montvoie, JU) vennero eseguite importanti opere di fortificazione. Il
significato storico del castello di Mesocco, considerato nel suo aspetto
definitivo, sta perciò nelle sue vicende costruttive, singolari per la
Svizzera, che si conclusero nel secolo XV con la costruzione di nuove opere difensive ed offensive per le con l'uso
dell'artiglieria. Sorprendentemente le ristrutturazioni del sec. XV,
nonostante le loro imponenti dimensioni, non hanno cancellato completamente,
qui, il concetto della fortificazione altomedievale, come invece è accaduto per
la fortezza di Hohentwiel nel Württemberg. Sono conservate la rocca, sorta
organicamente intorno al mastio (secc. Xll XV), l’area sacra del Primo e Alto
Medioevo intorno alla chiesa di S. Carpoforo e le parti dei bastioni medievali
sul lato ovest della rocca, dove lo strapiombo naturale rendeva superflue
ulteriori opere di fortificazione. I grandi lavori di ampliamento difensivo
dell'ultima fase della costruzione riguardarono soltanto il perimetro della
rocca sui lati nord-ovest, est e sud, dove vi era pericolo di attacchi
improvvisi da parte dell'artiglieria. L'ampliamento ad est dell'area
fortificata fino a comprendere la chiesa di S. Maria, aveva lo scopo di
respingere l'attacco di eventuali nemici dalle colline a sud-ovest della
chiesa, poiché sulle sue alture potevano essere installati potenti pezzi di
artiglieria con effetto disastroso per gli assalitori.
Come già esposto, il castello di Mesocco era una chiesa fortificata del Primo Medioevo e con ciò si inserisce in un più ampio gruppo
di fortificazioni, finora scarsamente studiate, che si trovano principalmente
nell'area della Rezia. Documenti scritti su tali chiese fortificate risalgono
al sec. Vlll. mentre scavi e reperti archeologici sembrano ricondurle fino ai
secc. Vl e VII. Sulla collina di Grepault presso Truns sono venute alla luce
tracce di una chiesa fortificata simile a questa e non trasformata da
costruzioni successive. Sono stati individuati i resti di una chiesa con abside
allineata e con una costruzione annessa così come le fondamenta di una cinta
muraria lungo il margine dell'area della rocca. A parte l'area sacra,
utilizzata costantemente, questo tipo di fortificazione dovette essere adibita
soltanto temporaneamente a rifugio.
Per lo
sviluppo delle chiese fortificate della Rezia in epoca alto e basso
medievale, si delineano secondo gli ultimi risultati della ricerca quattro situazioni tipiche:
1. abbandono di tutto l'insediamento prima del
Mille (Grepault):
2. abbandono della zona fortificata e
conservazione della chiesa (San Lorenzo di Paspels, Tiefencastel):
3. rinuncia alla cortina difensiva esterna,
mantenimento della chiesa, costruzione di un castello feudale su una superficie
ridotta (Steinsberg e chiesa di San Luzi presso Ardez);
4. conservazione della chiesa e della fortezza,
parziale o totale trasformazione di quest'ultima in un castello feudale
(Solavers, Jörgenberg, San Parcazi, Hohenrätien).
Il quarto
caso è quello più frequentemente documentato. Anche il castello di Mesocco
corrisponde a questo schema di sviluppo. Quando e in quale modo sia avvenuto il
passaggio dal rifugio, utilizzato temporaneamente al castello feudale
permanentemente abitato resta da ricercare caso per caso. I reperti di
Hohenrätien e Jörgenberg indicano che questo processo ebbe inizio con la
costruzione di una rocca feudale (sec. X-Xl?). Il progressivo ampliamento
dell'area feudale all'interno del castello non avviene in egual misura in tutti
gli insediamenti fortificati.
Nel castello di Mesocco la primitiva area
feudale è rintracciabile all'interno della rocca. L'ampia area del castello
deve aver costituito il rifugio primitivo. La trasformazione del castello in
residenza feudale, iniziata nel sec. Xll, comporta la scomparsa progressiva
della funzione di rifugio e l'occupazione di tutta l'area del castello con
costruzioni feudali (stalle, laboratori artigiani, magazzini, locali di
servizio). In nessun'altra chiesa fortificata della Rezia la trasformazione della zona adibita a rifugio
in castello feudale venne realizzata in modo così coerente e totale come
nel castello di Mesocco, conseguenza del perdurare delle opere di costruzione
fino alla fine del secolo XV.
Gli edifici medievali del castello, così come
ancora si sono conservati, rientrano nelle tradizioni
regionali. Ciò vale sia per la chiesa di S. Carpoforo, databile al sec. XI,
la cui abside scavata nella parete terminale della chiesa ha origine nella
Rezia, come anche per gli edifici profani (mastio, primitiva cinta muraria
della rocca, finestre e porte), che corrispondono alle tradizioni costruttive
dei castelli grigionesi. Nel corso dei sec. XIV è sempre più evidente l'influenza dell'Italia settentrionale. Essa
si esprime tra l'altro nella merlatura a coda di rondine, nelle scale esterne
in pietra e nelle logge, così come nei camini e negli impianti delle latrine.
Ancora secondo la tradizione italiana sono eseguite le fortificazioni della
fine del sec. XV, i merli, le torri per i pezzi di artiglieria, le porte
fortificate e le feritoie. Analoghe forme architettoniche si trovano ad esempio
a Bellinzona, nel castello di Morcote, come pure nella maggior parte delle
fortezze lombarde un tempo dipendenti da Milano.
Purtroppo le rovine del castello, dopo i
lavori di scavo e consolidamento del 1925/26, non hanno più avuto una
manutenzione costante per cui da allora si sono verificati gravi danni alla
muratura. È auspicabile che vengano adottati provvedimenti energici per
permettere un risanamento delle parti pericolanti e garantire la conservazione
di questo monumento storicamente significativo.