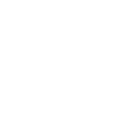Chiesa Santa Maria
Storia
CHIESA DI SANTA MARIA DEL CASTELLO
STORIA
DELLA COSTRUZIONE
La chiesa. sorta
probabilmente già nel primo millennio viene documentata per la prima volta
nella lettera di donazione a San Vittore del 1219. Non si può dimostrare se
nella navata attuale eretta al più tardi in età romanica, siano comprese parti
risalenti all’Alto Medioevo. Certamente al 1100 circa risale anche il
campanile. Come risulta dal Protocollo di Visitazione del 1583. si trattava di
una chiesa a sala con due absidi semicircolari a volta. Questa pianta non
frequente, che potrebbe essere sia del Primo Medioevo che romanica
sorprendentemente è documentata nei Grigioni in due altre località dell’Alta
Mesolcina. a Mesocco in S. Pietro e Paolo e a Cremeo in S. Pietro; inoltre si
riscontra a Chironico, Mendrisio (S. Martino), Reichenau-Mittelzell.
Il 23 gennaio 1450
il conte Enrico de Sacco-Mesocco donò a nome del fratello Giovanni un altare
dedicato ai ss. Giovanni Battista, Giorgio, Carpoforo, Antonio, Sebastiano,
Barbara, Caterina e tutti i santi. Il sacerdote fu incaricato
contemporaneamente di celebrare le messe funebri nel cimitero adiacente sopra
Ie tombe dei signori de Sacco-Mesocco . Questo ed altri due altari quello in
onore di s. Maria e quello dei Re Magi. vennero consacrati il 6 giugno 1459. La
riconsacrazione dell’altare maggiore e dei due laterali fa supporre che nel
decennio 1450/60 fosse stato portato a termine un radicale rinnovamento. Gli
affreschi della parete settentrionale e il dipinto della Madonna sulla parete
sud risalgono al più tardi al 1469 (vedi p.41).
Nel 1479 si ha
notizia di un quarto altare, quello della Croce. Poco prima del 1583 ebbe luogo
un ulteriore rifacimento, di cui tuttavia non conosciamo l'entità. Nel 1627
Mastro GIOVANNI BATTISTA VISCARDl da San Vittore, della rinomata famiglia di
architetti mesolcinesi, eresse un nuovo
coro dopo aver abbattuto le vecchie absidi e prolungato la navata di circa m 4
verso est. Contemporaneamente vennero ingrandite e ridistribuite le finestre.
Verso il 1680 seguì la costruzione della sagrestia. Nel 1720 venne rifatto
l’esterno e nel 1729 venne eretto il pulpito che fu addossato alla parete
settentrionale davanti agli affreschi.
Nel 1923 venne
eseguito un completo restauro della chiesa sotto la direzione dell’architetto
basilese MAX BACHOFEN, durante il quale il pulpito venne spostato sulla parete
sud. I dipinti murali della parete settentrionale vennero restaurati e in parte
completati (vedi p. 30).
Da allora la
chiesa è un monumento nazionale tutelato dalla Confederazione e dal 1976
dall'Ufficio Cantonale dei monumenti storici.
Nel 1974 è stato
eseguito un restauro dell'esterno diretto dall'ingegner WALTER GOLDER di
Roveredo.
DESCRIZIONE
DELL’EDIFICIO
La chiesa di S.
Maria sorge nell'avvallamento a nord della collina del castello, collocandosi
in un luogo poco visibile tra quest'ultimo e il paese. La cerchia delle mura,
in parte ancora conservata, era congiunta alla struttura fortificata del
castello. La chiesa. orientata a nord-est, consta di una sala rettangolare che
immette in un coro chiuso su tre lati, cui è annessa a nord una sagrestia
pressoché quadrata. Il prolungamento della navata medievale verso est (1627) è
riconoscibile a sud da un giunto distante m 4.2 dall'angolo a est: qui
s'interrompe anche lo zoccolo proveniente dal coro. Il portale della facciata
ovest è ad arco a tutto sesto ed ha un intonaco liscio. La porta in noce,
datata 1729, presenta modesti intarsi (stessa lavorazione del pulpito); sul
catenaccio ricompare la data 1729. L'entrata laterale con architrave
orizzontale appartiene alla fase del prolungamento del lato nord. Presso il
campanile è riconoscibile una vecchia porta murata con arco a tutto sesto che
immetteva nella navata. Il tetto a due falde è ricoperto di piode. Sul fronte
occidentale compare la data 1720 e il monogramma del capomastro «P.T.». La
sagrestia è aggiunta al lato settentrionale del coro.
Il campanile, sul fianco
meridionale della navata, è una snella costruzione
romanica (1100 circa), articolata in sei piani da archi ciechi
rispettivamente tripli e quadrupli. L'ultimo piano non presenta più gli
archetti ciechi sui lati est e nord, essendo stato rifatto. Le aperture
aumentano progressivamente dal basso verso l'alto secondo lo schema
architettonico romanico; nel piano più basso si aprono feritoie, nel secondo
sottili finestre con arco a tutto sesto ( monofore), nei quattro piani
superiori bifore con imposte oblique su sottili pilastrini senza basi e
capitelli.
Il tetto a quattro
falde è coperto di piode. Alla base del campanile. verso sud, è addossata una
nicchia con volta ad arco a sesto acuto che senza dubbio venne usata
successivamente come ossario, ma originariamente serviva come tomba secondo il
modello italiano. Una croce di Malta in rilievo sulla chiave di volta dell'arco
fa supporre che qui fosse stato sepolto Eberardo de Sacco-Mesocco, un figlio
del trovatore Enrico, documentato nel 1314 come cavaliere dell'Ordine dei
Gerosolimitani.
Durante l'ultimo
rifacimento del 1974 venne rifatto l'originario intonaco bianco, che attribuì
all'edificio il nomignolo di «S. Maria in bianco».
Affresco sulla
facciata principale v. pag. 39.
INTERNO
Il soffitto della
navata, presumibilmente del 1627. è costituito da una travatura in legno e da
una robusta listonatura longitudinale che lo suddividono in cassettoni
allungati. È decorato con volute d'acanto, motivi di pietre incastonate e fiori
dai colori vivaci di gusto popolaresco (giallo. azzurro. rosso, grigio e
bianco): al centro c rappresentata l'Assunta. Questa fitta decorazione risale,
stando all’iscrizione, al 1757 e venne eseguita. secondo quanto è testimoniato
dalla firma dell'artista apposta sulla prima trave a ovest, da «JOANNES SEPP DE
SUMVITCHS» (Somvix). Gli archi delle finestre nelle pareti sud e ovest sono a
sesto ribassato: ornamenti in rosso. azzurro e grigio, simili a quelli del
soffitto, decorano le loro nicchie e le coronano di ricchi timpani, offrendo un
effetto d'ingrandimento ottico. Nella parete d'ingresso si aprono inoltre una
lunetta e due finestre per la preghiera.
Il coro, aggiunto nel 1627 alla
navata prolungata verso est, venne decorato con stucchi rococò solo nel
1720. Su fondo marroncino-grigiastro, scandito da nastri blu che sottolineano
la forma della volta rappresentante il cielo, sono stati eseguiti stucchi in
bianco: lungo i nastri si svolgono volute di foglie e ramoscelli tra cui si
mescolano già motivi di conchiglie. graticci, rocailles e figurine di angeli.
Ai capi dei nastri vi sono i veri e propri elementi della decorazione in
stucco: medaglioni con i rilievi dell'Annunciazione, della Natività,
dell’Assunzione e dell’immacolata Concezione. Nella decorazione del coro si
inserisce l’altare maggiore la cui
sovrastruttura in stucco a motivi neoclassici risale probabilmente alla prima
metà del secolo XIX.
La pala proviene
da un altare più antico: Maria con una veste color rosso-lilla e un mantello grigio-azzurro sopra la falce lunare
tiene il Bambino in braccio, circondata da una corona di raggi e da paffuti
angeli sorridenti che la incoronano Regina del Cielo. Sotto vi sono gli stemmi
Brocco. Toscano e Nigris con le iscrizioni «FISCHALE THOMAS BROCCO ANNO 1634» e
SR MLLE (MINISTRALE) G10. DE NIGRO»; inoltre, si
legge D’URANIA PIN.: resto della sigla dell’autore del dipinto. Si tratta del
maestro «M CH» (MATHIS CHEFELER) del Canton Uri.
I due altari laterali
presso l'ingresso del coro sono simili tra loro
nell'edicola decorata in turchese e oro con colonne e timpano spezzato:
risalgono al 1630-40.
L 'altare dei Re Magi
(a sinistra, sul lato del corno dei Vangeli) è
sormontato da un dipinto dell'Epifania in sfumature di toni caldi e scuri con
figure accuratamente modellate: probabilmente è contemporaneo alla pala
dell'altare maggiore e forse è opera dello stesso artista. Sull'altare di S. Giovanni (a destra. sul lato del corno
dell'Epistola) è rappresentato il Battesimo di Cristo nel Giordano (ritoccato).
Sui paliotti di questi due altari si trovano due putti alati che reggono drappi
realizzati a stucco in una lavorazione fortemente plastica, e tra questi,
incorniciati d'acanto, gli stemmi che si riferiscono ai patroni degli altari. A
sinistra sono rappresentate tre corone; a destra la capanna di s. Giovanni
sulla riva del Giordano e. di fianco. il bastone con la croce del Battista
(1700 ca.). L'altare della Croce, addossato
alla parete sud, è il vero e proprio altare «delle grazie», come dimostrano le
offerte votive appese accanto. Oggetto di devozione era originariamente un
dipinto eseguito in una nicchia quadrata nella parete. che in un primo momento
non faceva probabilmente parte di un altare. Esso raffigura Maria col Bambino e
davanti a loro s. Caterina in un gruppo che s'ispira al tema del mistico
sposalizio della santa di Alessandria con Cristo (seconda metà del sec. XVI).
Palesemente solo all’inizio del sec. XVIII venne costruito intorno a questo
dipinto. che aveva guadagnato frattanto la venerazione popolare, un altare in
stucco, formato da un'edicola con due colonne di gusto piuttosto grossolano.
L'affresco originario, in parte danneggiato e in parte ritoccato. fu coperto
con un dipinto a olio di scarso valore artistico dello stesso soggetto. La vera
e propria pala d'altare. al di sopra di questa piccola tela, si riferisce
all'Adorazione della Croce e rappresenta il Bambino Gesù in grembo a s.
Giuseppe. Due angioletti in volo portano la croce come annuncio del sacrificio
della vita; a destra, un legionario romano è inginocchiato e impugna un
vessillo crociato. Si tratta di una pittura artigianale del sec. XVIII.
Accanto, a destra, è appeso il cosiddetto «dipinto
degli spazzacamini», datato 1830; porta la dedica degli spazzacamini di
Mesocco che andavano a lavorare a Vienna e da là portarono con sé in patria
questo quadro come ricordo. A colori vivacissimi vi è rappresentata la Madonna,
Regina del Cielo, con in braccio il Bambino, entrambi adornati di corone di
rose. Il pulpito originariamente sulla parete nord e, dopo
il 1923 su quella sud, è datato 1730. È in legno di noce, poligonale, con
pilastrini tortili agli angoli e piede curvilineo. La copertura è a forma di
cupola con viticci intarsiati. Al 1729 risalgono gli stalli del coro, scanditi da pilastri tortili. Secondo i libri dei
conti, i lavori di falegnameria e intarsio vennero diretti dai maestri ANDREAS
TESCHER, JAKOB PORTSCHER e KASPAR HOESLI. L'acquasantiera in marmo bianco risale al 1650 circa.